L’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – nel quale il 59% dei votanti ha manifestato la propria contrarietà alla riforma della Costituzione promossa e sostenuta dal Governo Renzi – ha determinato quattro principali conseguenze sul piano politico-istituzionale: 1) le dimissioni del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi; 2) la conseguente crisi di Governo con successiva nomina di un nuovo esecutivo, guidato da Paolo Gentiloni; 3) una situazione di grande incertezza per quanto attiene il sistema elettorale; 4) la chiusura – quantomeno nel breve periodo – del discorso sulle riforme costituzionali.
La personalizzazione del referendum e le dimissioni di Renzi – Per quanto attiene alla prima questione – vale a dire le dimissioni del premier – pare necessario innanzitutto sottolineare come la decisione di Renzi di legare il proprio futuro politico all’esito referendario – e dunque di personalizzare tale consultazione – non abbia comportato (come invece è stato sostenuto da alcuni) alcun vulnus democratico. Se è vero infatti che i plebisciti personalistici sono tipici di regimi illiberali (si pensi a Napoleone prima, e ad Hitler e Mussolini poi), è altresì vero che anche alcuni leader di grandi Paesi democratici non si sono fatti scrupoli nel personalizzare determinate consultazioni popolari. Tutti i referendum tenutisi sotto de Gaulle, ad esempio, divennero – per volontà del Generale stesso – plebisciti sulla sua persona. Più di recente, anche il premier greco Alexis Tsipras dichiarò che avrebbe rassegnato le dimissioni qualora la popolazione avesse votato “sì” al referendum svoltosi il 5 luglio 2015 sulle condizioni stabilite dalla c.d. Troika (Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale) per concedere un nuovo supporto finanziario al Paese.
Diceva Maurice Duverger riferendosi alla prassi gaullista (ma tale osservazione può perfettamente estendersi anche ai referendum/plebisciti di Tsipras e Renzi) che queste consultazioni popolari divengono spesso “una sorta di questione di fiducia sottoposta al Paese”. Un abuso dei plebisciti personalistici è senza dubbio da evitare, ma certamente essi non paiono incompatibili con regimi di tipo democratico: in questi ordinamenti, infatti, il voto è realmente free and fair, grazie a partiti che partecipano attivamente alla campagna referendaria, ad una stampa libera, ed al fatto che le possibilità che si verifichino brogli elettorali tali da condizionare il risultato finale sono pressoché inesistenti.
In secondo luogo, va evidenziato come la decisione di Renzi di personalizzare il referendum del 4 dicembre abbia rappresentato un atto di coerenza. D’altronde, che tale Governo avesse fatto delle riforme costituzionali una delle sue priorità pare un dato incontrovertibile. Presentandosi alle Camere per chiedere la fiducia, infatti, Renzi chiarì come l’azione dell’esecutivo sarebbe dovuta partire dalle “riforme costituzionali, istituzionali ed elettorali, sulle quali si è registrato un accordo che va oltre la maggioranza che sostiene questo Governo, e per il quale noi non possiamo che dire che gli accordi li rispetteremo nei tempi e nelle modalità prestabilite”. Qualcuno ha forse obiettato che quello non dovesse essere un punto programmatico dell’esecutivo?
Non va dimenticato, poi, che l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano aveva affermato di “condivid[ere] profondamente l’accento che è stato posto dal Presidente Renzi sulla esigenza – e lo ha posto in modo drammatico – di adottare in tempi brevi le riforme strutturali per le istituzioni e per l’economia e il lavoro che non possono ulteriormente attendere”. Insomma, nulla quaestio sul fatto che tale Governo fosse chiamato a fare le tanto auspicate, ma mai realizzatesi riforme costituzionali.
Renzi, che in un primo momento aveva addirittura dichiarato che avrebbe abbandonato la vita politica in caso di vittoria del “no”, altro non poteva fare quindi (da un punto di vista politico) se non rassegnare le proprie dimissioni in seguito alla sconfitta referendaria. Una scelta obbligata, in altre parole. Non sono mancate, peraltro, critiche sul fatto che questi non abbia altresì lasciato la carica di segretario del Partito democratico.
E’ opinione comune (e ad ogni buon conto corretta) quella secondo cui la personalizzazione di tale consultazione abbia fortemente penalizzato l’ex premier. Per quanto si sia rivelata sbagliata strategicamente, essa tuttavia – vale la pena ribadirlo – non può in alcun modo considerarsi incompatibile con un ordinamento democratico come quello italiano, e difficilmente non può non essere considerata un atto di coerenza per un Governo (ed una legislatura) di tipo “costituente”.
La crisi di Governo e la nascita del Governo Gentiloni – Con le dimissioni di Renzi – formalizzatesi il 7 dicembre – si è aperta ufficialmente la crisi di Governo, la quale si è tuttavia risolta in tempi estremamente rapidi. L’11 dicembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, ha infatti assegnato l’incarico di formare un nuovo Governo a Paolo Gentiloni, il quale già il giorno seguente si è recato al Quirinale per sciogliere la riserva, comunicare al Capo dello Stato la lista dei ministri e quindi prestare giuramento. Nei due giorni successivi il Governo ha ottenuto a larga maggioranza la fiducia nei due rami del Parlamento.
Una rapida risoluzione della crisi non può che essere accolta positivamente, specie se si considerano le numerose ed importanti sfide a cui è chiamata l’Italia nei prossimi mesi. Sfide non solo interne (si pensi alla questione degli istituti bancari in crisi, all’emergenza nelle zone terremotate, o ancora alla perdurante crisi economica che continua a frenare crescita e occupazione), ma anche internazionali. A marzo, infatti, Roma ospiterà le celebrazioni per i sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma; dal 1° gennaio, poi, l’Italia ha assunto la presidenza del G7, il cui prossimo vertice si terrà a maggio a Taormina; a novembre, infine, all’Italia spetterà la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, di cui è membro non permanente dal 1° gennaio.
Va evidenziato come il nuovo Governo si inserisca in un quadro di continuità rispetto al precedente esecutivo. Lo stesso Gentiloni lo ha sottolineato chiaramente già in diverse occasioni, come nel discorso alla Camera con cui ha chiesto la fiducia (“Rivendico il grande lavoro che abbiamo fatto, i risultati che ci vengono riconosciuti a livello internazionale e di cui siamo orgogliosi”), o nel discorso di fine anno (“cancellare o relegare nell’oblio” il lavoro fatto dal Governo Renzi “sarebbe un errore”). Tale continuità risulta, poi, più che mai evidente se si considera che il nuovo esecutivo è composto in larga misura dagli stessi ministri di cui faceva parte il precedente Governo. I prossimi mesi mostreranno se questa continuità rappresenti un punto di forza ovvero una debolezza per l’esecutivo guidato da Gentiloni, e come essa ne condizionerà l’azione. In ogni caso, tra le numerose incognite che pesano sull’azione e sulla durata del Governo, una delle maggiori è senz’altro quella legata alla legge elettorale.
La legge elettorale, i partiti e la Corte costituzionale – La bocciatura della riforma costituzionale nel referendum del 4 dicembre ha reso ancora più complessa la questione legata alla legge elettorale. L’Italicum, infatti, era stato previsto nell’ottica di una Costituzione “riformata”, nella quale solo un ramo del Parlamento (la Camera dei Deputati) sarebbe stato direttamente elettivo (e infatti solo ad esso si sarebbe applicato l’Italicum), mentre l’altro (il Senato della Repubblica) sarebbe stato eletto non già dai cittadini, bensì dai consiglieri regionali. Stante, tuttavia, una Costituzione “invariata”, entrambe le Camere continuano ad essere direttamente elettive, ma con leggi elettorali profondamente diverse: l’Italicum, infatti, regola l’elezione della Camera, mentre il c.d. Consultellum (ossia il Porcellum (la precedente legge elettorale) “depurato” dai profili di incostituzionalità rilevati dalla Corte costituzionale con la sentenza 1/2014) disciplina l’elezione del Senato. La prima prevede un sistema proporzionale a doppio turno con una forte correzione maggioritaria, mentre la seconda consiste in un proporzionale quasi puro. Se si andasse a votare con tali leggi elettorali, le probabilità di ritrovarsi con un Parlamento sostanzialmente paralizzato sarebbero altissime.
Modificare la legge elettorale è dunque un imperativo ineludibile, e infatti tutte le forze parlamentari si sono impegnate in tal senso. Non è chiaro, tuttavia, se e fino a che punto quelle stesse forze siano disponibili ad accordarsi su una nuova legge e, nel caso, quanto tempo ci vorrà a raggiungere un compromesso. Molto dipenderà dalla sentenza della Corte costituzionale (prevista per il 24 gennaio) sulla legittimità costituzionale dell’Italicum. Fare previsioni su tale giudizio è quantomai rischioso, specie se si considera il precedente della sentenza 1/2014 sul Porcellum: in tale occasione, infatti, i giudici della Consulta avevano sorpreso gran parte degli osservatori (e dei costituzionalisti) non tanto per il giudizio sul merito (poiché già in altre pronunce la Corte aveva invitato il legislatore a procedere alla modifica della legge elettorale), quanto per il fatto stesso di avere dichiarato ammissibile la questione di costituzionalità. Da un punto di vista strettamente tecnico, infatti, tale questione sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile. Fu soprattutto il contesto politico a spingere la Corte ad una “forzatura” sul piano procedurale ammettendo la questione e potendo così sindacare nel merito la costituzionalità della legge. Alla luce di questo precedente, fare previsioni sulla sentenza del 24 gennaio pare davvero un azzardo.
Una cosa, tuttavia, è certa, vale a dire che i giudici della Consulta si ritrovano in questo mese di gennaio nel bel mezzo dell’agone politico. Difatti, oltre al giudizio sulla legittimità costituzionale dell’Italicum, la Corte sarà altresì chiamata a verificare l’ammissibilità di tre referendum abrogativi promossi dalla Cgil contro il c.d. Jobs act. Una pronuncia particolarmente delicata, soprattutto alla luce del fatto che il quesito principale – quello sulla tutela da applicarsi in caso di licenziamenti illegittimi (secondo l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori) – è a forte rischio di inammissibilità.
E le riforme costituzionali? – Come ampiamente prevedibile, a distanza di poco più di un mese dal referendum del 4 dicembre il tema delle riforme costituzionali è già finito nel dimenticatoio, ed è pressoché impossibile che se ne riparli a breve. La bocciatura referendaria non consente in alcun modo, tuttavia, di mettere la testa sotto la sabbia: indipendentemente, infatti, dal giudizio espresso da ciascuno sulle modifiche proposte dal Governo Renzi, la riforma della seconda parte della Costituzione rimane una questione di fondamentale importanza che dovrà essere nuovamente affrontata al più presto. Non farlo significherebbe allargare ancor di più la distanza tra testo scritto e Costituzione vivente.
Francesco Biagi è Senior Research Fellow presso la Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law (Heidelberg), e Researcher presso il Center for Constitutional Studies and Democratic Development (Bologna). Ha conseguito il dottorato in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Ferrara. Le posizioni espresse in questo articolo rappresentano esclusivamente il pensiero dell’autore.

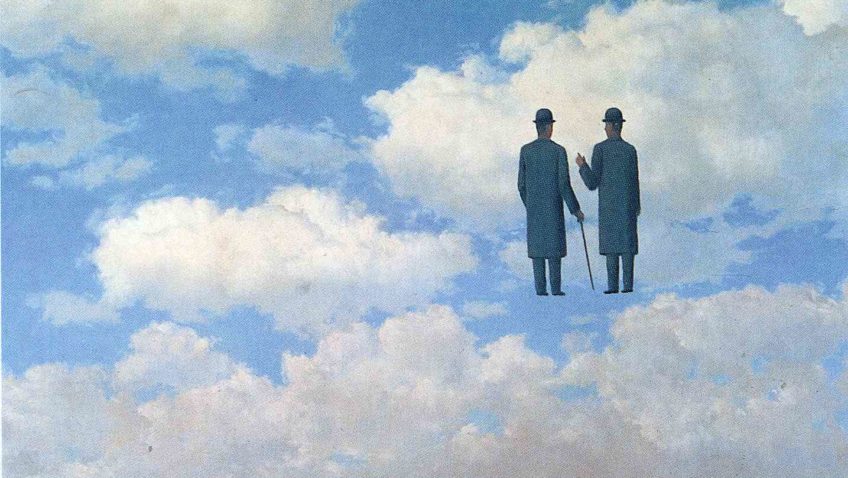


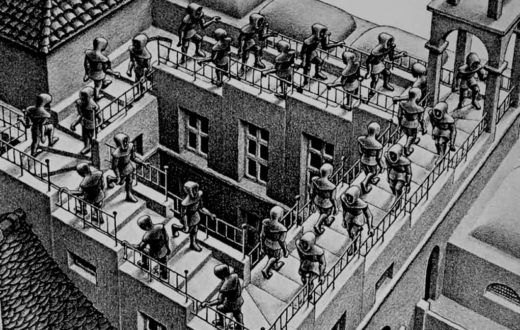



0 comments